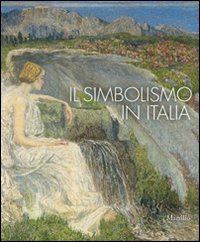La mostra di Palazzo Zabarella sulla coinvolgente stagione del Simbolismo mette a fuoco gli episodi che fecero di quello scorcio di secolo un vero e proprio laboratorio della sensibilità moderna, un crocevia di eccezionale vivacità creativa in tutti i campi dell'arte che seppe instaurare singolari analogie fra pittura e letteratura, fra queste e la musica, fra la filosofia e gli stessi comportamenti di intellettuali eccentrici il cui obbiettivo era di far coincidere la vita con l'estetica e le avventure dell'immaginazione.
Organizzato in sezioni tematiche, il percorso della mostra si svolge dagli anni Ottanta del XIX secolo per giungere sino alla vigilia della prima guerra mondiale: un arco di tempo che comprende dunque la crisi degli entusiasmi postunitari e delle certezze maturate in seno al pensiero positivista; l'insorgere delle inquietudini che troveranno espressione nelle poetiche del Decadentismo europeo, alimentate dalla scoperta dell'inconscio e dal suo bagaglio di inedite suggestioni: il sogno, il mito, l'enigma, il mistero; la celebrazione idealista dei valori universali dell'umanità nel momento stesso in cui l'avanzare del progresso scientifico e tecnologico sembrava minacciarli inesorabilmente. Sullo sfondo del manifesto di Jean Moréas del 1886 e del dibattito teorico sostenuto anche in Italia da artisti e letterati in antitesi alle correnti naturaliste e veriste, la mostra documenta con opere fondamentali le diverse 'capitali' di quella stagione simbolista e decadente che giungerà sino alla rivolta futurista.
Per prima Roma, dove il cenacolo di artisti raccolti intorno a Gabriele D'Annunzio e Angelo Conti (Costa, De Carolis, Sartorio) traggono ispirazione dall'arte dei preraffaelliti, la quale favorirà la svolta idealista e la concezione del paesaggio come manifestazione degli stati d'animo; quindi la Milano dei divisionisti, con Grubicy, Previati e Segantini che proclamano un'arte sperimentale nello stile e 'ideista' nei contenuti; infine Torino, dove i temi sociali trattati da Bistolfi e Pellizza da Volpedo trovano nel simbolo e nella natura trasfigurata il mezzo per comunicare l'utopia di un auspicato progresso sociale e spirituale. Quindi Venezia e Trieste, quali sperimentali avamposti della cultura italiana verso i grandi movimenti contemporaneamente in atto nella Mitteleuropa.
L'obbiettivo della mostra è inoltre quello di documentare i contatti dei nostri pittori con i grandi simbolisti stranieri presenti in Italia, dai ricordati preraffaelliti a Böcklin, Puvis de Chavannes, Klinger, Von Stuck, Klimt, conosciuti attraverso le Biennali di Venezia: a questo proposito costituirà un evento di sicura presa spettacolare la ricostruzione della famosa Sala del Sogno che alla Biennale del 1907 rappresentò la consacrazione ufficiale di un movimento in cui si era per buona parte riconosciuto lo spirito nazionale di fine secolo.
A conclusione del percorso - corredato fra l'altro di 'cesure' dedicate ai capolavori dell'editoria (come l'